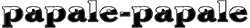teatro
Parioli Peppino De Filippo – Roma
Una Pura Formalità
Versione teatrale del film di Giuseppe Tornatore
di Giada Gentili
Una Pura Formalità
Teatro Parioli - Roma
fino al 13 Aprile
Con Glauco Mauri,
Roberto Sturno
Scene: Giuliano Spinelli
Costumi: Irene Monti
Musiche: G.Mazzocchetti
Regia: Glauco Mauri
Libero adattamento
dal film di G.Tornatore

Da oltre trenta anni insieme sulle scene, Glauco Mauri e Roberto Sturno con immutato impegno e totale dedizione al Teatro aggiungono nuovi capitoli alla storia di una “ditta” all’antica italiana che felicemente coniuga impresario, attore, regista per creare nuovi e inediti adattamenti.
Nei teatri di tutta Italia hanno portato i grandi classici: Sofocle, Shakespeare, Goethe, Molière, ma anche Ionesco e Beckett, Pirandello e Goldoni, Dostoevskji e Brecht, Mamet e Schmitt, Shaffer e Andreev, fino ad oggi con la versione teatrale del film di Giuseppe Tornatore “Una pura formalità”.
Quando il film uscì nelle sale nel 1994 fu accolto, per la sua inquietante novità, con una certa difficoltà da parte della critica. Oggi è considerato uno dei suoi film più belli in assoluto; un “piccolo capolavoro”, ne erano protagonisti Gérard Depardieu e Roman Polanski con un giovanissimo Sergio Rubini.
Recital di Poesie
Tra teatro e didattica
Teatro Lo Spazio – Roma

Voce recitante
Margherita Lamesta Krebel
Musiche e luci
Francesco Verdinelli
Presentazione e regia
Alberto Bassetti
Lo spettacolo nasce con l’intento di far ascoltare ai giovanissimi, ma per una volta fuori dalle mura scolastiche, la voce dei grandi poeti: e dove, meglio che a teatro, si possono mescolare parole, musica ed emozioni?
Le poesie proposte spaziano da dal I sec. a.C. al 1900.
Le tematiche sono tante, diverse e coinvolgenti: dall’amore gioioso per una donna alle lodi per il Creato, dallo scherzo pungente all’ “amor corte-se”, dalla sepoltura epica di un re barbaro allo struggimento del patriota esule, dai versi del poeta che si diverte con le parole al pessimismo cosmico, dall’impegno civile contro la guerra alla scanzonata ironia verso la famiglia reale “che non ha saputo contare fino a venti”.
Autori e testi
Catullo - S. Francesco d’Assisi - William Shakespeare - Giacomo Leopardi
Dante Alighieri - William Shakespeare - Giacomo Leopardi - Giosuè Carducci
Giovanni Pascoli - Gabriele D’Annunzio - Aldo Palazzeschi - Umberto Saba
Eugenio Montale - Salvatore Quasimodo - Bertold Brecht - Jaques Prévert.


Tema centrale di Una pura formalità: la ricerca della memoria. Gli squarci che si aprono nella mente del protagonista durante il serrato interrogatorio in uno “strano” commissariato ricostruiscono il suo passato, risalgono alle sue origini con continui colpi di scena, e come in un thriller lo spettatore arriva alla verità con un inatteso finale.
“L’intensità del racconto, il suo ritmo, illuminato da emozionanti colpi di scena, una razionale e al tempo stesso commossa visione della vita – dice Glauco Mauri – mi hanno spinto, in pieno accordo con Tornatore, ad una libera versione teatrale.
Già il film ha una sua struttura sospesa fra cinema e teatro e questo mi ha molto aiutato nel lavoro. E come negli “incontri” fortunati, la storia così magnificamente raccontata nel film, ha fatto germogliare in me emozioni inaspettate che diventavano sempre più mie.
Un’opera tanto più è valida quanto più dona a un interprete la possibilità di scoprire sfumature umane e poetiche in essa nascoste.
Ho cercato di far rivivere tutta la forza drammatica della sceneggiatura modificandone quelle parti che si presentavano con dei connotati troppo cinematografici, preservandone al tempo stesso quell’intensità che dall’inizio ci avvolge nel suo misterioso intreccio”.

Il racconto rimane oscuro fino al suo sconvolgente epilogo dove i pezzi lacerati di una vita si compongono in una serenità inaspettata e commovente: un capovolgimento radicale di quello che sembrava un giallo.
Un delitto è stato commesso e ne viene accusato un celebre scrittore, Onoff.
Ma, pur con la tipica atmosfera di un thriller, “Una pura formalità” è un viaggio alla scoperta di se stessi, di quella che è stata la propria vita.
“Gli uomini sono eternamente condannati a dimenticare le cose sgradevoli della loro vita; e più sono sgradevoli e prima si apprestano a dimenticarle”. Ecco quello che scrive in uno dei suoi romanzi Onoff, che nella lunga notte di Una pura formalità cerca ansiosamente di ricordare… ricordare… cosa?

Un altro uomo aiuta Onoff in questa faticosa ricerca di un passato che si è voluto dimenticare: un inquietante commissario di polizia, un personaggio duro e ironico, comprensivo ma implacabile…
Non può non sovvenire il ricordo del grande Dostoevskij e il rapporto tra Porfirij e Raskolnikov in Delitto e Castigo.
Tutto si svolge in una sperduta stazione di Polizia. Ma lo è veramente? E dove si trova? E quelle strane persone al suo interno, sono poliziotti? Cosa aspettano?
La storia fa nascere numerosi interrogativi ed è pervasa di “misteriosi perché”.
Il cinema ha le sue ricchezze espressive, il teatro ne ha altre che sono sue proprie. E su un palcoscenico, nel nostro caso, la parola assume un valore non solo di racconto ma anche di invito alla fantasia e alle domande. Domande necessarie all’uomo per aiutarlo a cercare di comprendere quel viaggio a volte stupendo e a volte terribile ma sempre affascinante che è la vita.