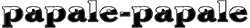Cultura e societÀ
Sarzana (La Spezia)
Festival della Mente 2013
Interviste ai protagonisti
a cura di Elena Marchini
Umberto Curi - Giuseppe Festa - Virgilio Sieni - Davide Ciferri - Teresa Porcella – Massimo Cirri - Carlo Freccero - Massimo Montanari – Nicola Gardini – Ferdinando Scianna – Lella Costa – Tim Parks – Alessandro Begonzoni - Luca Barcellona
A proposito
della bellezza
Intervista a Umberto Curi
Da dove nasce nell’uomo l’esigenza della ricerca del bello?
Per rispondere adeguatamente, sarebbe necessario anzitutto chiarire come si concepisce la bellezza. Se per “bello” si intende infatti una forma privilegiata, tale da proporsi come oggetto di una “degustazione” fine a se stessa, non credo che corrisponda ad una vera e propria esigenza, presente in tutti gli uomini. Fatte le debite precisazioni, qualcosa di simile si potrebbe dire anche a proposito del bello artistico, di quello che non compare in “natura”, ma è il risultato di un’attività, di quella che i Greci chiamavano techne, e che è insieme “arte” e “tecnica”. In altre parole, se si assume il bello riduttivamente come ciò che, in senso lato, è pertinente a quella disciplina che è l’estetica, dubito che sia possibile parlarne come un’esigenza diffusa e condivisa universalmente. Tutt’altro discorso si dovrebbe fare ove si intendesse la bellezza non come un contenuto determinato, e perciò anche contingente e suscettibile di apprezzamenti differenti, ma come espressione di un’eccedenza, come rinvio ad una ulteriorità che resta irraggiungibile. In questa accezione, il bello è inseparabile dal “bene” e dal “vero”, e coincide dunque con una istanza di compiutezza, con lo slancio verso una dimensione di totalità, destinato a restare comunque insoddisfatto. Questa esigenza – di superamento dei propri limiti – è comune a tutti e scaturisce specificamente da una tensione connaturata alla condizione umana.
Umberto Curi è professore emerito di Storia della filosofia presso l’Università di Padova e docente presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. È stato visiting professor presso le Università di Los Angeles e di Boston, Collabora al supplemento La lettura del Corriere della Sera. Le sue pubblicazioni includono: Miti d’amore. Filosofia dell’eros (Bompiani, 2009); Straniero (2010, Premio Frascati), Passione (2013) per Raffaello Cortina Editore; Polemos. Filosofia come guerra (2000), La forza dello sguardo (2004), Meglio non essere nati. La condizione umana tra Eschilo e Nietzsche (2008, Premio Capalbio 2009 e Praemium Classicum Clavarense 2010), Imparare a morire (2011), L’apparire del bello (agosto 2013) per Bollati Boringhieri.
Quale cultura si è interrogata maggiormente circa il bello e la bellezza?
Senza la pretesa di stilare classifiche, non vi è dubbio che il tema della bellezza è al centro di una delle due componenti della tradizione culturale alla quale apparteniamo. Nel filone greco-latino, infatti, ben più che nel versante giudaico-cristiano, l’interrogazione sulla bellezza ha assunto un’importanza decisiva, proprio in conseguenza della stretta indissolubilità posta fra bello, vero e bene. Nel mio libro - L’apparire del bello. Nascita di un’idea, Bollati Boringhieri, in uscita alla fine di agosto- cerco di analizzare alcuni passaggi chiave di questa tradizione: Saffo e Pindaro, Omero e Tucidide, Tirteo e Sofocle. E poi, soprattutto, i grandi classici – Platone, Aristotele, Plotino – che al bello hanno dedicato pagine di straordinaria intensità e suggestione. Basti pensare al nesso fra bellezza e amore, di cui si tratta nel Simposio platonico; o ai criteri per potere giudicare kalos una tragedia secondo Aristotele; o, ancora, alla bellezza intesa come “cara patria”, alla quale ritornare, come Ulisse a Itaca, nella prima delle Enneadi. Insomma, un patrimonio ricchissimo, in larga misura ancor oggi scarsamente conosciuto e, soprattutto, non adeguatamente compreso e interpretato.
Quale filosofo, secondo lei, ha dato una delle più interessanti definizione di bellezza?
Mi rifiuto di stilare graduatorie. I filosofi non sono calciatori, attori o cantanti, per i quali sia dunque possibile predisporre una hit parade. E poi: con quale criterio – prima ancora di incolonnarli in una improbabile classifica – posso distinguere i filosofi da quelli che non lo sono? Da anni combatto una battaglia di totale minoranza per disimpegnare gli autori dalle categorie bibloteconomiche (e dalle rigidità accademiche) con le quali vengono arbitrariamente assegnati ad una disciplina. Leopardi e Kafka, Musil e Becket sono o non sono filosofi? E, prima ancora, quale senso avrebbe una considerazione del pensiero greco classico che fosse mutilata dei nomi di Sofocle e Euripide, di Tucidide e Ippocrate? Sarebbe ora di riconoscere che l’importanza di un autore non dipende dalla possibilità di ricondurne l’opera ad un settore scientifico-disciplinare come quelli usati per i concorsi universitari. Detto questo, vi sono alcune liriche di Rainer Maria Rilke, e alcune pagine di Walter Banjamin (per restare nel Novecento), o alcune abbaglianti riflessioni di Platone, che mi sembrano poter essere indicate non tanto come “definizioni” della bellezza, quanto piuttosto come accensioni problematiche, come quel balenare improvviso, a cui lo stesso Platone riconduce l’interrogazione filosofica.
Qual è il collegamento tra mente e bellezza?
Almeno a prima vista, il collegamento tra mente e bellezza sembra essere quanto meno arduo, se non del tutto impossibile. Ma ciò dipende appunto dal prevalere di una certa concezione della bellezza. Fino a che si continuerà a considerare il bello come ciò che si offre alla degustazione, sarà inevitabile ritenere che esso sia appannaggio dell’”estetica”, e cioè di una disciplina che riguarda le sensazioni, e che dunque non coinvolge la mente. Viceversa, se si riconosce che la bellezza non è distinta, né ancor meno contrapposta, rispetto a quella realtà che si è soliti evocare col termine mente, potrà emergere un dato sorprendente. E’ proprio con la mente – così ci insegnano alcuni autori, da Platone a Rilke – che possiamo “vedere” ciò che altrimenti sfuggirebbe ai sensi. Anzi: il bello è proprio ciò verso cui tendo attraverso un percorso intellettuale, capace di superare i limiti della mera sensibilità. Si potrebbe parlare di una sorta di itinerarium mentis in pulchrum, di una ricerca che valorizza le migliori attitudini umane. Conducendoci non già in un “altrove” , che resta comunque irraggiungibile. Ma piuttosto mettendoci a confronto con i nostri limiti.
Viandanti per natura
intervista a Giuseppe Festa
Che rapporto hanno i bambini di oggi con la natura e l'ambiente?
Come avviene per molti altri aspetti della loro vita, anche il rapporto con la natura è mediato e filtrato dai media e da Internet. Molti bambini sanno vita, morte e miracoli dei leoni o dei rinoceronti visti nei documentari in tv, ma quasi nessuno conosce l'esistenza di animali che vivono nel bosco dietro casa. Sono davvero poche le famiglie che hanno il tempo di far fare ai bambini esperienze significative a contatto con la natura. Anche il ruolo dei nonni, una volta importantissimi nel tracciare un filo di continuità e di conoscenza col mondo naturale e con gli antichi saperi, sta diventando marginale. E questo è davvero triste.
Giuseppe Festa, laureato in Scienze naturali, si occupa di educazione ambientale progettando percorsi per le scuole. Scrittore e musicista, è cantante e autore del gruppo dei Lingalad. La sua musica ha incontrato un vasto consenso di critica e di pubblico e lo ha portato a esibirsi su prestigiosi palcoscenici internazionali. Ha pubblicato Il passaggio dell’orso (Salani Editore, 2013).
A suo avviso quanto le scuole educano le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente?
Il ruolo della scuola oggi è importantissimo. Un tempo i bambini costruivano da soli i propri sentimenti per la terra, durante i lunghi pomeriggi trascorsi con gli amici a giocare e a esplorare la natura. Oggi questo non avviene più: da un lato le famiglie non si fidano a lasciare soli i figli all'aperto, dall'altra i bambini sono sommersi da attività extra scolastiche quali nuoto, calcio, danza, judo, musica e chi più ne ha più ne metta. Non c'è tempo per rincorrere lucertole o esplorare il greto di un torrente.
Con tutti gli stimoli da cui sono bombardati quotidianamente i bambini, una passeggiata in mezzo alla natura come viene percepita?
I bambini si costruiscono dei filtri per sopravvivere al bombardamento della società di oggi. Lo facciamo tutti. Gli input che ci arrivano, se non ci costruissimo delle barriere protettive, ci distruggerebbero in breve tempo. Era ciò che succedeva ai nativi americani o agli aborigeni australiani quando andavano a vivere nelle città dai bianchi. Sfortunatamente ci portiamo dietro questi filtri anche quando ritorniamo nella natura. D'altro lato, i bambini sono in grado di recuperare velocemente il filo diretto con ciò che li circonda. Ecco perché è fondamentale far fare loro esperienze a contatto con la terra prima che siano troppo grandi.
Durante questo tipo di esperienza cosa colpisce immediatamente l'attenzione dei bambini?
Se si focalizza la loro attenzione sulle piccole meraviglie del mondo naturale, si sorprendono di quanto varie siano le forme e i colori della natura, quando a prima vista un bosco appare loro solo verde e marrone, e con ben pochi animali in circolazione. Se poi si riesce a fargli apprezzare il fatto di stare in silenzio, si meravigliano dell'infinità di voci diverse che giungono alle loro orecchie e che fino a pochi attimi prima erano coperte dal frastuono delle loro grida.
Si ricorda qualche domanda bizzarra fattale da un bambino a cui non ha potuto/saputo dare una risposta?
Più che domande bizzarre, i bambini fanno cose bizzarre (indotte dai genitori, nella maggior parte dei casi). Una volta un bambino tirò fuori un guanto per lavare i piatti e cominciò ad esplorare il sottobosco con addosso quell'affare giallo. Mi disse che la madre glielo aveva dato per evitare di toccare cose velenose... Altri bambini non ne vogliono sapere di sedersi per terra poiché temono di sporcarsi i pantaloni. Una volta incontrai una bambina che aveva una vera e propria fobia per il fango. L'idea di sporcarsi anche solo la suola delle scarpe la inorridiva. Al primo torrente, mi avvicinai alla riva e mi dipinsi faccia e braccia con il fango, imitato da altri bambini. Incredibilmente, dopo aver constatato quanto ci stessimo divertendo, lo volle fare anche lei. Alla fine della giornata era la bambina più felice - e infangata - che avessi mai visto.
Quando portiamo nella natura i bambini, conta molto di più il nostro entusiasmo che le nostre parole.
Di fronte agli occhi degli altri
intervista a Virgilio Sieni
Qual è stato il suo percorso artistico-professionale?
Virgilio Sieni coreografo e danzatore, si è formato nella danza classica e contemporanea ad Amsterdam, New York e Tokyo. Nel 1983 ha fondato la compagnia Parco Butterfly, trasformata nel 1992 in Compagnia Virgilio Sieni, riconosciuta oggi a livello internazionale come una delle maggiori realtà europee nel campo, legata ai più importanti teatri e festival europei, che affianca alla creazione di spettacoli un programma di ricerca, studio e diffusione del linguaggio coreografico contemporaneo. Ha creato coreografie per le principali istituzioni teatrali italiane.
Non è facile riassumerlo in poche parole, diciamo che è stato cruciale tutto il periodo degli anni ’70, in cui mi sono avvicinato all’arte, all’arte visiva, alla body art, al living theatre, in cui ho frequentato la facoltà di architettura, corsi di danza classica e contemporanea a New York, e di arti marziali a Tokio.
Può raccontarci un momento indimenticabile della sua carriera?
Un momento che ricordo molto volentieri è il periodo giapponese, in cui ho approfondito con diversi maestri tante discipline tra cui quella del teatro Nō.
Se dovesse dare una definizione di danza, che cosa direbbe?
La danza prima di tutto è una sospensione, una realtà legata all’idea di costellazione, la danza è quasi un’idea cosmica.
Come nasce una sua coreografia?
È un percorso molto articolato, non esiste un metodo predefinito, molto spesso nasce da uno sbriciolamento di intuizioni, ma il più delle volte è necessario il confronto con gli altri, con gli interpreti.
Che cosa trasforma una coreografia in qualcosa di magico e indimenticabile?
È la capacità di lasciare intuire qualcosa di inedito, far sì che il pubblico stesso si sposti insieme all’artista in un territorio nuovo.
Al Festival della Mente ha proposto Di fronte agli occhi degli altri, una riflessione sulla Resistenza. A suo avviso come il linguaggio del corpo può dare ancora voce alla Storia?
Il corpo include tutto quello che è stata la nostra storia, dal primo seme, dal primo uomo. Nel corpo emerge già la nostra storia e la nostra antropologia, il corpo è quindi un continuo mettere in gioco le memorie.
Scelgo dunque sono. Il gioco dell'economia
intervista a Davide Ciferri
Al Festival della Mente insieme al professor Di Colli ha spiegato alcuni concetti dell’economia ai bambini; iniziamo dallo spread, un concetto un po’ nebuloso a tutti ma che da circa due anni ha condizionato la nostra esistenza. Come si può spiegare ai bambini lo spread?
Davide Ciferri è docente di Econometria alla John Cabot University ed economista presso l’Ufficio Studi della Cassa Depositi. Ha scritto con S. Di Colli €conomia! Una scienza da scoprire, dal baratto allo spread (Lapis Edizioni, 2012).
Si, forse lo spread è un concetto un “po’ nebuloso” anche se paradossalmente è anche abbastanza facile da calcolare. Più complesso è capire a quali concetti e problemi economici è collegato. Con i bambini cerchiamo di ripartire proprio dai concetti fondamentali connessi allo spread e cioè: debito pubblico, tassi d'interesse e avversione al rischio. Di solito parliamo sempre di due amici immaginari: Italo e Angela. Il primo è purtroppo disoccupato, non ha un lavoro e non ha quindi uno stipendio certo. Angela invece ha un lavoro che le permette di guadagnare dei soldi ogni mese. Sia Italo che Angela hanno bisogno di un po’ di soldi per comprarsi una macchina nuova ma non possono aspettare di risparmiare i soldi necessari per l'acquisto. A questo punto chiediamo ai bambini: a chi presteresti voi i soldi? E quanto gli fareste pagare di interesse?
Generalmente, quasi tutti vorrebbero prestare i soldi a Angela perché pensano che sia un prestito "più sicuro", ma facilmente si capisce che si possono prestare dei soldi a Italo, anche se in questo caso bisognerebbe chiedergli un “prezzo” maggiore, proprio perché Italo, essendo disoccupato, potrebbe non essere in grado di restituire il prestito. Quindi, maggiore rischio, significa maggiore interesse: ecco spiegato lo spread. Anche gli Stati, infatti, come le persone si possono trovare nella condizione di chiedere dei soldi in prestito. Italo e Angela potrebbero essere l'Italia e la Germania. Se l'Italia, per una serie di ragioni, è considerata più rischiosa della Germania, allora gli interessi che i risparmiatori le chiederanno saranno maggiori di quelli che chiederanno alla Germania. Lo spread, come dice anche la parola stessa, è la differenza tra gli interessi chiesti all'Italia e quelli che vengono chiesti alla Germania, o se volete quelli tra quelli chiesti a Italo e quelli chiesti ad Angela. Purtroppo questo giochino non sempre funziona. Una volta una bambina ci circa 8 anni chi ha risposto: “io i soldi li darei a Italo, perché è disoccupato e ne ha più bisogno”... sarebbe bello se anche il mondo della finanza ragionasse, almeno qualche volta, come quella bambina.
Altro argomento caldo, le tasse, perché nel nostro paese sono percepite come una punizione?
Le tasse sono viste come punizione perché il cittadino giudica mediamente poco efficienti e di scarsa qualità i servizi che lo Stato offre "in cambio" di queste tasse . Ma questo è vero fino a un certo punto. Penso ad esempio alla Sanità e alla Scuola che nonostante notevoli difficoltà continuano ad offrire un servizio fondamentale per lo sviluppo e la coesione della nostra società. In questo credo che influisca anche una deriva di tipo culturale, purtroppo prevalente, che vorrebbe l'individuo sempre più libero rispetto ai doveri verso la collettività che invece sono sanciti in maniera così evidente nella nostra Carta Costituzionale.
Una volta abbiamo fatto un gioco con i bambini chiamato “Pagare le tasse è bello?” parafrasando un economista ed ex-Ministro dell'economia. Alla fine del gioco, i bambini ci hanno risposto: “Beh, pagare le tasse proprio bello non è, ma forse è utile”.
Perché sono diventati così importanti parametri come l’ammontare del debito pubblico?
Per due ragioni. Il primo è che l'ammontare del nostro debito è davvero enorme... come sappiamo supera i 2.000 miliardi di euro. In una crisi come quella che stiamo vivendo in questi anni, la nostra capacità di far fronte a un debito così grande viene messa in discussione, soprattutto dagli investitori internazionali, e questo ci porta al secondo aspetto: con la globalizzazione finanziaria tutto il nostro sistema economico è diventato più vulnerabile. La globalizzazione offre delle opportunità enormi anche da un punto di vista economico, ma pone anche delle sfide altrettanto grandi. E questa è una di quelle. Essere un'economia solida e credibile è fondamentale per restituire certezze ai mercati che ci giudicano quotidianamente attraverso le loro decisioni di investimento. Il problema dell'elevato debito pubblico non è un problema di oggi, ma è qualcosa che ci portiamo dietro da decenni. Negli anni passati, con un ciclo economico e interessi più favorevoli abbiamo perso l'occasione di affrontare il problema della riduzione del debito in maniera più forte. Oggi paghiamo le conseguenze di quella miopia, principalmente politica, e dobbiamo essere consapevoli che il percorso di risanamento delle finanze pubbliche comporterà sacrifici importanti nei prossimi anni con effetti negativi anche sulle generazioni future. Questa è forse la cosa più difficile e triste da spiegare ai bambini.
In conclusione, secondo lei, come potremo uscire da questo declino economico? Ce la faremo?
Certo che ce la faremo. La principale domanda non è "se", ma "come" (e "quando") usciremo dalla crisi. Ogni crisi porta con sé un cambiamento, culturale prima che economico. Dobbiamo saper cogliere con determinazione le opportunità che questa crisi ci potrà offrire; è il momento di rimboccarsi le maniche, moltiplicare gli sforzi e mettere a servizio di tutti i talenti che ognuno ha nella certezza che questo servirà a migliorare il benessere individuale e quello collettivo. Per dirla con le parole di Einstein durante la Grande Crisi degli anni '30: "(...)Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla”.
Cadaveri squisiti ed emozionatissimi
intervista di Teresa Porcella
Teresa Porcella, laureata in Filosofia, si occupa di libri per ragazzi come autrice, progettista ed editor, svolgendo anche attività di formazione e laboratori. Per Motta Junior ha ideato e cura la collana di poesia «Il suono della conchiglia» e quella di narrativa «BUS». Ha fondato l’Associazione Scioglilibro (2005), finalizzata alla promozione della lettura. Il suo ultimo libro è Dammi una mano (Motta Junior, 2012).
Quale è stato il percorso che l’ha portata a occuparsi di libri per bambini e ragazzi?
È stato un percorso articolato; ho studiato filosofia del Rinascimento, una volta finito il percorso universitario mi sono occupata dapprima di multimedia, cioè di architetture del pensiero, quindi ho deciso di dedicarmi alla letteratura per ragazzi come redattore per l’editoria scolastica, come autrice e poi come docente di letteratura per l’infanzia all’università. La molla che mi ha portato a occuparmi di infanzia è stato un compromesso tra il vissuto e le proiezioni che si fanno per il futuro, i bambini hanno memoria corta e desideri lunghi, al contrario degli adulti che hanno memoria lunga e desideri corti, questo significa che la tipologia di spinta vitale è molto differente, quella del bambino è tendenzialmente più sana, e trovo che questo sia un ottimo motivo, per un adulto, per entrare in contatto con il mondo e con la letteratura dell’infanzia. Occuparmi di letteratura per bambini non è stato solo un’esigenza di igiene mentale, ma anche una scelta di allegria.
Quali sono i generi letterari più congeniali ai bambini?
Ai bambini piace una serie di cose che gli adulti non gli danno. I bambini, ad esempio, adorano la poesia. La poesia ha un approccio di tipo analogico e sonoro, assolutamente congeniale alla mente del bambino. Ai bambini, infatti, piacciono i giochi di parole, le assonanze, le rime perché si trovano in una fase di sperimentazione del linguaggio.
Cosa cercano i bambini nelle favole?
Cercano dei percorsi per conoscersi. La favola è un mondo protetto per esplorare la realtà, non solo quella esterna, ma molto più spesso quella interiore. Con le fiabe i bambini devono divertirsi, devono imparare a esplorare, devono sentirsi rassicurati di avere un referente esterno.
Chi racconta oggi le favole ai bambini?
Sarebbe un discorso molto lungo e complesso. I genitori hanno sempre meno tempo da dedicare alle favole, e questo è il problema della nostra società. Se si dedica poco tempo ai bambini si perde non solo la quantità ma anche la qualità del rapporto. Le relazioni infatti necessitano di tempi estesi. Anche nelle scuole l’ascolto delle favole, delle narrazioni, è relegato alle scuole delle infanzia e diminuisce drasticamente già alle scuole primarie.
Crescendo nell’adolescenza si mantiene il piacere della lettura?
Molto poco, resta comunque il fatto che i ragazzi leggono molto più degli adulti. L’adolescenza, ovviamente non si può parlare di adolescenza come di un’entità monolitica, è l’età dove si verifica un forte divario tra maschi, che leggono meno, e femmine che sono più interessate alla lettura.
Sense of humour: uno stile di vita / Nuove paure, vecchie paure
intervista a Massimo Cirri
Al Festival della Mente ha trattato di sense of humor e di paure. Non le sembrano due argomenti in antitesi? E il sense of humor può essere utile a superare le paure?
Massimo Cirri, psicologo e giornalista, lavora nei servizi pubblici di salute mentale. È stato autore televisivo, ha ideato i RadioIncontri di Riva del Garda e dal 1997 è autore e voce di Caterpillar su Radio2. Autore teatrale.
Un po’ si. Credo che però ci sia un legame profondo tra sense of humor e paura, perché la paura, o per lo meno un certo utilizzo pubblico delle paure, la costruzione della dimensione della paura, che è stata molto praticata in questo paese per usi politici, può essere scardinato con i meccanismi dell’ironia. Credo, ad esempio, che il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, abbia vinto le elezioni perché ha scardinato con l’ironia le tesi del suo contendente basate sulle paure. Quindi a mio avviso andrebbe studiato di più questo legame tra paure e disarticolazioni delle paure, attraverso i meccanismi dell’ironia. Perché l’ironia come ci ha spiegato Jonathan Coe (ndr. lo scrittore inglese è stato protagonista al Festival della Mente insieme a Massimo Cirri dell’intervento Sense of humour: uno stile di vita) è la capacità di lavorare su piani diversi della comunicazione, è un importante strumento di riflessione personale e collettiva.
A proposito di sense of humor, quali benefici si possono rilevare in chi affronta la vita con sense of humor?
Dicono che se si ride, si muore un po’ dopo. Ridere scarica una tensione. A livello fisico, quando ci capita di ridere, anche insensatamente, sentiamo una tensione che si scioglie, sentiamo che ci liberiamo di qualcosa. A livello intellettuale, credo che il sense of humor e la risata siano strumenti che ci permettano di elaborare i dolori e le nostre fragilità.
Qual è il livello di sense of humor nel nostro paese?
Mi sembra che ci sia, e sia abbastanza praticato.
Prima ha citato la politica, anche nella politica si riscontra sense of humor?
No, tra i politici mi sembra che ci sia pochissimo sense of humor. C’è stata una grande stagione, interpretata da certa satira politica, come Cuore e Tango, in cui il più grande partito comunista d’occidente si è interrogato su se stesso e poi si è dissolto, grazie agli strumenti della satira e dell’autoironia.
È possibile imparare il sense of humor?
Siamo animali culturali, si può imparare il sense of humor da bambini per contaminazione culturale, a questo proposito Lella Costa ha scritto uno splendido manuale in cui ha indicato cosa può essere utile da far leggere ai bambini per imparare e capire l’ironia. Dopo, crescendo, credo che non ci sia alcuna speranza...
La televisione ha ucciso la creatività e la cultura?
intervista a Carlo Freccero
Da molti è considerato uno degli innovatori, da altri un guru, della Tv, quando ha iniziato a fare televisione e perché?
Per caso. Mi fu dato un catalogo cinematografico con 350 titoli di una grande casa cinematografica, la Titanus, per cui dovevo scrivere una scheda per ogni film, questo catalogo andò in mano a Silvio Berlusconi che mi incontrò nella redazione del Giornale e mi chiese di andare a programmare i film nella sua televisione che allora era poco più di una tv di quartiere. Per curiosità e per pazzia decisi di provare. Dalla programmazione dei film, sono passato a fare tutti i lavori televisivi, scrivere gli annunci, organizzare i palinsesti. Da lì ho iniziato. Era la fine degli anni settanta, si parla di archeologia della tv commerciale.
Carlo Freccero, nato a Savona nel 1947, è stato responsabile del palinsesto televisivo in Fininvest e ha diretto Rai 2 dal 1996 al 2002. Grande esperto di comunicazione e media, è attualmente direttore di Rai 4. Nel corso della sua esperienza professionale ha attraversato tutte le fasi della televisione: dalla televisione commerciale, con Canale 5, Rete 4, La Cinq e Italia 1, al servizio pubblico, con France 2, France 3 e Rai 2, alla tv satellitare, con Rai Sat, per approdare infine alla tv digitale.
Quale aspetto le piace del mezzo televisivo?
Tutto. Ho fatto tutti i tipi di tv, la tv generalista commerciale e la tv generalista del servizio pubblico, ho lavorato per la tv su satellite e per la tv digitale, e ho avuto la fortuna di lavorare in due paesi, in Italia e in Francia.
Tutte queste diverse tv hanno portato delle innovazione nel mezzo televisivo tradizionale?
Ogni tv ha una sua storia, una sua identità. Per innovare occorre plasmare l’esistente, conoscere la materia su cui si opera, essere accademici. Il creativo, conoscendo quello che esiste, deve essere capace di prendere le distanze dal conformismo, prendere le distanze dalla cultura main- stream. Questo è ancora più vero oggi che la tv è accerchiata dai nuovi media, è un sistema integrato con il web, ed è obbligata a fare i conti con questo nuovo tipo di fruizione in cui il pubblico non è più un soggetto passivo.
Ha parlato di identità televisiva, esiste ancora una qualche differenza tra televisione pubblica e commerciale?
Credo di sì. È vero che molte volte si rischia di confonderle, e c’è una certa sovrapposizione. La televisione del servizio pubblico ha però un plus, cioè è in grado di creare una condivisione, una cerimonia mediatica, una fruizione comune, e inoltre ha una memoria storica. Nei momenti più salienti la tv del servizio pubblico torna ad essere centrale, diventa il fulcro di tutto. Se venisse a mancare questo aspetto sarebbe una tragedia, perché significherebbe che la tv del servizio pubblico avrebbe perso la sua funzione.
In questi anni si parla sempre più spesso di quanto la politica invada la televisione, ma cosa è cambiato secondo lei rispetto a quaranta anni fa?
Tv e politica è uno dei temi più importanti. Negli anni Sessanta la tv, diretta da un’elite, aveva una funzione pedagogica, era un prolungamento del servizio pubblico, ma era chiaramente censurata, tendeva a proteggeva il cittadino, non a caso dalla televisione pubblica non si è mai saputo nulla del caso di piazza Fontana. Negli anni Ottanta si chiedeva invece al telespettatore di interagire con la tv, la tv libera lo spettatore. Mani pulite è l’esempio di come non esistesse più filtro, e la televisione dà visibilità alla politica. Negli ultimi anni, l’anomalia italiana ha creato un dibattito sulla politica in tv, che ha invaso i palinsesti della televisione. In questo dibattito, il pubblico ha l’impressione che la tv possa creare una democrazia diretta, oggi, infatti, non sarebbe più possibile, come nel 2002, un nuovo editto bulgaro, perché la tv è assediata dagli altri media. Oggi la tv vive di questa libertà; sebbene la politica voglia controllare la tv, questo controllo è molto più difficile, perché è cambiato scenario. Oggi il potere usa la tv per raccontarsi, ma la tv svela il potere.
Qual è il programma televisivo che più le è piaciuto fare?
Non riesco a sceglierne uno, sono tutti miei figli; indicandone uno, farei un torto alle persone con cui ho lavorato, con le quali ho avuto un rapporto di complicità
Parlare di cibo al tempo della crisi
intervista di Massimo Montanari
Che interazioni esistono tra società e cibo, dal punto di vista culturale?
Esiste un’interazione totale, nel senso che il cibo, inteso come prodotto di un lavoro che inizia dalla terra, e subisce un percorso di preparazione, esprime in maniera perfetta tutte le identità culturali della società, i suoi rapporti interni, i suoi progetti. Il cibo è forse l’elemento più semplice, per ricostruire i parametri culturali di una società.
E a questo proposito come definirebbe la nostra società dal suo stile alimentare?
La nostra società è in transizione, in cambiamento, sta vivendo un ripensamento sulla propria identità di società industriale. Abbiamo avuto un passato di società agricola, in cui il rapporto il rapporto con il cibo era diretto, la stragrande maggioranza della popolazione conosceva il processo attraverso cui il cibo nasce, si trasforma, si prepara e si consuma. Con l’industrializzazione tutto questo viene meno, nella società industriale il rapporto con il cibo viene delegato ad altri, all’industria, alla ristorazione, ai commercianti, e il rapporto con il cibo tende a cadere nell’ignoranza, cioè alla non conoscenza.
La transizione di cui faceva riferimento ci sta quindi riportando a una maggiore conoscenza del cibo?
Penso di sì; oggi esiste una domanda di conoscenza molto forte, un desiderio di riappropriarsi di questo rapporto diretto con il cibo che di fatto negli anni è venuto meno.
Massimo Montanari insegna Storia medievale e Storia dell’alimentazione all’Università di Bologna, dove dirige il master europeo in Storia e cultura dell’alimentazione. Fra i suoi lavori più importanti: L’alimentazione contadina nell’alto Medioevo (Liguori Editore, 1979); Atlante dell'alimentazione e della gastronomia (curato con F. Sabban, UTET, 2004) La fame e l'abbondanza (1993) Il cibo come cultura (2004): È anche autore di un manuale di storia per gli istituti secondari superiori: Vivere nella storia (3 voll., Editori Laterza, 2012).
Questa tendenza è riscontrabile anche nella propensione di molti ad avere, anche i città, un proprio orto?
Certo, gli orti cittadini sono una moda, ma le mode indicano anche tendenze ed esigenze. Orti in città e trasmissioni televisive dedicate al cibo e all’alimentazione se osservati attentamente sono espressioni di un desiderio di prendere contatto con il cibo. Mi pare che quest’attenzione ai processi produttivi, alla semplificazione della filiera commerciale e alla preparazione del cibo a livello domestico sia propria soprattutto delle generazioni più giovani.
In quest’educazione al cibo mette anche i programmi televisivi?
In realtà i programmi televisivi dedicati al cibo, che hanno preso il sopravvento nei palinsesti, sono tante cose. Alcuni hanno coniato a questo proposito la definizione pornografia alimentare, cioè una cultura del cibo da guardare in modo compulsivo ed eccessivo che non necessariamente indica tutto quello che ci siamo detti prima. Però credo che la pornografia alimentare in televisione, al cinema, sulla carta stampata sia espressione di un bisogno più o meno inconsapevole di riappropriarsi di questa conoscenza, come dicevo prima soprattutto nelle giovani generazioni che hanno ripreso a cucinare in casa.
Quindi i giovani non sono più attratti dal junk food?
Secondo me sono più attenti a ciò che mangiano. I fast food non sono più di moda e sono scelti solo per motivi conviviali o economici. Questa attenzione del cibo da parte dei giovani ha portato a cambiare anche le tendenze alimentari proposte dai fast food, dal ridimensionamento delle carni, alle proposte di piatti di verdure, alla valorizzazione di prodotti locali. Il fast food è passato dalla globalizzazione del cibo, almeno da un punto di vista comunicativo, alla contro-globalizzazione.
In conclusione, come è nato il suo interesse storico-culturale nei confronti del cibo? Essere romagnolo ha avuto un peso?
Non so da dove nasca quest’interesse, può darsi che la provenienza geografica mi abbia influenzato. Quello che posso dire è che il mio interesse per il cibo è nato dopo il mio interesse per la storia. Studiando storia dell’alimentazione mi sono accorto di quanto fosse un argomento ricco di sollecitazioni e mi sono aperto anche alla cultura gastronomica.
La lacuna
intervista di Nicola Gardini
Nel suo intervento al FdM ha parlato di omissioni in letteratura, ci può fare un esempio di omissione, come l’ha definita lei, “che parla”?
Nicola Gardini insegna Letteratura italiana presso l’Università di Oxford ed è fellow del Keble College. Autore di numerosi saggi, articoli, poesie e opere narrative, ha tradotto W.H. Auden (Un altro tempo, Adelphi, 1997), E. Dickinson (Buongiorno notte, Crocetti Editore, 2001). Nel 2012 ha vinto il Premio Letterario Viareggio-Rèpaci per Le parole perdute di Amelia Lynd (Feltrinelli, 2012), «una esortazione a ricercare con forza il nucleo di verità che, come insegna Leopardi, è nelle parole».
Un caso molto clamoroso è l’inizio del XXI canto dell’Inferno in cui Dante si preoccupa di dire al lettore che stava parlando con Virgilio di altro che il poema non si preoccupa di riportare “Così di ponte in ponte, altro parlando che la mia comedìa cantar non cura”. Un’affermazione del genere ha del sensazionale, perché lo scrittore deve dirci che non ci sta dicendo tutto? Che cosa si stavano dicendo Dante e Virgilio? E perché non dobbiamo sapere cosa si stavano dicendo? In questo caso, Dante chiede al lettore di assumere un ruolo attivo, di interpretare, e di ingegnarsi. L’attivazione di curiosità nelle forme di narrazione omissiva è finalizzate a dare al lettore il compito attivo di completare il senso.
Quindi l’omissione è sempre una scelta voluta? Ed è sempre percepita dal lettore?
Assolutamente sì, è sempre volontaria. Quello che mi interessa individuare nei testi letterari è un’estetica dell’omesso, la deliberata costruzione di un meccanismo narrativo che consideri i vuoti alla stregua dei pieni, e li annunci. Un lettore disattento li prenderà per vuoti di sinteticità o di frettolosità; in realtà sono vuoti pieni di tesori. Esistono lacune clamorose, e testi più sottili, però ogni buon testo è omissivo. Anche Cicerone suggeriva che un buon discorso non è quello che dice tutto, ma quello che indica all’ascoltatore dove cercare.
Quali sono i generi letterari che più si prestano all’omissione-sottrazione?
Un po’ tutti i generi letterari. Però con Edgar Allan Poe nasce un genere che si presta particolarmente alle omissioni: le detective story, il racconto poliziesco. Arthur Conan Doyle ha perfezionato il genere con il personaggio di Sherlock Holmes. Un altro genere specializzato in omissioni è il linguaggio cinematografico che dà l’illusione di continuità, mentre è una serie di frammenti organizzati in sintassi.
Anche nel linguaggio giornalistico è possibile omettere-sottrarre-eliminare?
Si, quando si tratta di giornalismo-saggistica. Anche la prima pagina di giornale in realtà è un’insieme di omissioni, dove si trovano tanti frammenti, lacune, delle cose più diverse. Il giornalismo ha però dei doveri professionali per cui è necessaria una certa completezza.
Memoria e fotografia
Ferdinando Scianna, fotografo di fama mondiale, entra nel 1982 nell’agenzia Magnum Photos. A un’attività critica e giornalistica alterna reportage, ritratto, fotografia di moda e di pubblicità, con successo internazionale. Oltre a Feste religiose in Sicilia (Leonardo Da Vinci, 1965), che inaugura una serie di collaborazioni con Leonardo Sciascia, tra i suoi libri ricordiamo: Baaria Bagheria (con G. Tornatore, 2009), Ombre (con M. Paladino, 2012), Ti mangio con gli occhi (2013) per Contrasto Due
intervista di Ferdinando Scianna
Ricorda la sua prima fotografia?
La prima fotografia può essere quella in cui mi sono identificato e ho scoperto che poteva essere qualcosa di più del divertimento di fotografare gli amici in gita. La mia prima fotografia, in questo senso, l’ho scattata che ero un ragazzo e ho fotografato la mia compagna di scuola, quella più carina. E forse per questo ho deciso di fare il fotografo.
Ha avuto dei maestri?
Non ho avuto altro. Mi considero un allievo professionale. Di mestiere faccio l’allievo. Poi da allievo sono diventato epigono. Il mio maestro fondamentale per quanto riguarda la fotografia è Cartier Bresson, per quanto riguarda invece la vita e la cultura è stato Leonardo Sciascia, che è stato per me padre, amico e maestro.
C’è una delle sue fotografie che la rappresenta?
È come domandare a una madre quale figlio preferisce, probabilmente dentro al suo cuore c’è un figlio preferito, ma non glielo dirà mai.
Esiste una fotografia che avrebbe voluto scattare ma non ne ha avuto mai la possibilità?
Milioni, tutte le mie fotografie migliori purtroppo non le ho fatte. Sono come i cacciatori che raccontano a lungo della lepre più bella che però non hanno mai preso.
Prima ha citato Sciascia, però anche Borges ha avuto una certa influenza nella sua vita professionale?
Sciascia,come le ho detto, è stato un pilastro fondamentale della mia esistenza, è stato l’incontro più fortunato della mia vita, che mi ha aiutato a capire il senso delle mie fotografie. Borges è figlio di un amore che mi è stato comunicato da Sciascia, è stato un incontro assolutamente memorabile, perché era un uomo all’altezza del suo mito. Io ho l’orgoglio di aver fatto, come qualcuno ha detto, la serie di fotografie più intense a Borges, e questo basta a giustificare la mia vita di fotografo.
Di cosa parliamo quando parliamo di ironia
intervista di Lella Costa
Perché e quando ha iniziato a scrivere e raccontare di ironia?
Prima ancora di fare questo lavoro ho avuto una propensione all’ironia. Più tardi per il mio lavoro ho iniziato ad usare l’ironia, perché era un bel modo di raccontare storie. Poi è successo che nel 2011, Oscar Farinetti mi propone di fare una lezione sull’ironia nella tenuta di Fontanafredda, e di lì a poco è nato un libro.
Nel libro 100 parole per la mente ha scritto che l’ironia è “l’essere capaci di modificare il proprio punto di vista” non c’è il rischio di fraintendere l’ironia con la volubilità?
Certo c’è il rischio che qualcuno fraintenda questi due concetti. In realtà credo che duttilità e disponibilità siano un antidoto potente a tutti gli assolutismi e gi integralismi. Temo molto quelli che hanno una visione del mondo che non si sposta mai. Si dice che solo i cretini non cambiano mai idea, quindi l’ironia è la disponibilità a cambiare i propri punti di vista. Spero che un po’ di ironia riesca a smantellare l’auto-referenzialismo, uno dei mali peggiori di oggi.
Lella Costa è una delle più amate autrici e attrici teatrali italiane. Dopo l’esordio nel 1980 con il monologo Repertorio, cioè l’orfana e il reggicalze, debutta nel 1987 con il primo spettacolo di cui è anche autrice, Adlib, a cui seguiranno, tra gli altri, Un’altra storia (1998) Precise Parole (2000) e Traviata(2002) con la regia di Gabriele Vacis; Femminile e singolare. Impegnata anche con la televisione, il cinema e la radio, è autrice di La sindrome di Gertrude. Quasi un’autobiografia (con A. Càsoli, Rizzoli, 2009); Come una specie di sorriso (Piemme, 2012).
Esistono degli indizi che ci fanno capire se una persona è dotata di ironia?
È un po’ difficile perché spesso si tende a confondere l’ironia con l’essere spiritosi, l’ironia non fa necessariamente ridere, è uno strumento di indagine, fa male. Penso alla popolarità di certi aforismi di Oscar Wilde che in realtà sono intrisi di una certa amarezza. Si può riconoscere se una persona è ironica lanciando un’esca e vedere se viene colta. Se una persona riconosce l’ironia, non ne è immune. Bisogna invece rifuggire le persone che dicono di essere molto ironiche.
I politici sono dotati di ironia?
Temo che ironia e potere siano incompatibili. Nel meccanismo del potere esiste una così assoluta coscienza, consapevolezza e assoluzione di sé, tale da non prevede l’ironia. Ed è un problema non essere in grado di cambiare il proprio punto di vista in un momento come questo, in cui c’è un totale scollamento percettivo del mondo da parte di chi lo governa rispetto a chi lo vive.
Che cos’è il contrario di ironia?
Non saprei perché è un vocabolo che si presta a molti significati. Per me il contrario di ironia è assolutismo, integralismo, rigidità, mancanza di duttilità.
Lei ha citato Oscar Wilde, ma oggi chi secondo lei è un esempio di ironia?
Dire Franca Valeri è una banalità, ma forse non lo si dice mai abbastanza; così come è ironico Woody Allen.
Entrambi hanno rapidità di pensiero e la capacità di raccontare il mondo in maniera dinamica, cioè modificando il loro punto di vista in funzione dell’età, perché con il passare gli anni la percezione del mondo cambia.
In conversazione con la creatività letteraria
intervistas di Tim Parks
Nel suo intervento al FdM si è interrogato perché le persone non sono d’accordo sulla letteratura, personalmente quale libro letto in quest’ultimo anno ha trovato particolarmente interessante?
Ho letto alcuni autori assolutamente strepitosi come Lydia Davis, vincitrice quest’anno dell’International Book Prize (ndr. Tim Parks è uno dei membri della giuria dell’International Book Prize), che scrive racconti cortissimi, belli e molto curiosi. Oppure lo scrittore indiano Ananthamurthy, con storie impregnate della sua cultura, ma senza lo spirito didascalico di chi deve spiegarla agli occidentali. E poi sicuramente i romanzi strepitosi di Aharon Appelfeld.
In genere cosa predilige in un romanzo: la trama, lo stile, i personaggi?
Non ho prescrizione. Nei libri in genere si cerca le cose che appartengo al proprio vissuto, che si sono conosciute e apprezzate nel passato. A volte capita che aprendo un libro si rimanga scettici, ma proprio questo è la cosa che può spiazzare. È importante essere aperti a ogni soluzione. Non bisogna mai cercare quello a cui si è abituati. Chi legge sempre lo stesso genere letterario, o cerca solo la trama, o lo stile, è come chi mangia sempre pasta: si preclude tutti gli altri cibi.
Tim Parks, nato a Manchester, abita in Italia da più di 30 anni. Romanziere e professore di lingue presso l’Università IULM di Milano, scrive regolarmente per The New York Review of Books e Il Sole 24 ore. Ha tradotto opere di Moravia, Tabucchi, Calvino, Calasso, Machiavelli e Leopardi ed è autore di vari saggi che esplorano le curiosità della vita italiana.. La sua più recente pubblicazione in Italia è il romanzo Il sesso è vietato (Bompiani, 2013).
Non le chiedo quale libro non l’abbia annoiato, però volevo sapere cosa ne pensa del diritto del lettore, sancito da Pennac, di non finire un libro che non piace? L’ha mai fatto?
Io sono molto impaziente, non do molte pagine a un libro se non mi seduce, soprattutto se non trovo qualcosa di veramente autentico. Avevo scritto un pezzo per il New York Review of Books, in cui dichiaravo che il lettore non solo può interrompere un libro se non piace, ma può smettere di leggere anche un libro che gli piace, può arrivare a tre quarti del libro e decidere che non esiste nessun motivo per finirlo. Molto spesso nella narrativa, accade infatti che i finali non convincono; chi legge Dostoevskij fa benissimo a interrompere il libro a tre quarti, tutte le cose importanti sono state dette nella prima parte del libro, alla fine ci sono solo le giustificazioni dello scrittore.
Quindi interrompere un libro non è un atto irrispettoso del lettore?
No assolutamente, anzi credo sia molto importante seguire i propri ritmi. Non si può finire un libro con lo stesso spirito di chi continua a mangiare un piatto solo perché l’ha pagato. Credo sia molto utile evitare anche di leggere un libro perche molti lo giudicano bello, proprio perché ognuno ha gusti diversi.
Nel suo intervento ha parlato molto di Pavese, come è cambiato il ruolo dello scrittore oggi rispetto alla prima metà del Novecento?
Pavese è stato uno scrittore estremamente affascinate. Come è cambiato il ruolo dello scrittore da Cesare Pavese a Sandro Veronese? Molte cose sono cambiate. Resta fermo che lo scrittore scrive non tanto perché ha qualcosa da dire. Molto spesso, infatti, il romanzo è un evento nella vita dello scrittore, è un tentativo di mettere in equilibrio certe forze che rischiano di disturbarlo. Scrivere è un modo per mettersi in rapporto con il lettore e fa parte della strategia di vita dello scrittore, del suo star bene psicologicamente. Le cose che sono cambiate sono invece, sia il mondo delle case editrici, sia che si scrive sempre meno a un pubblico locale e sempre più a un pubblico internazionale a discapito dello stile linguistico.
No al geniocidio! (Dall’estro al creame)
intervista di Alessandro Bergonzoni
Cosa significa la parola Geniocidio?
Alessandro Bergonzoni, autore e attore teatrale, dal 1982 ha scritto e interpretato 14 spettacoli, con i quali ha vinto tutti i principali premi teatrali italiani. Si è imposto con Non è morto né Flic né Floc (1987), e con la trilogia Predisporsi al micidiale (2004), Nel (2007) e Urge (2010) si è definitivamente affermato come uno degli autori più originali e amati del teatro contemporaneo italiano. Collabora con il Venerdì di Repubblica. Dal 2005 si avvicina anche al mondo dell’arte esponendo in gallerie e musei italiani ed europei. Ha debuttato come scrittore con Le balene restino sedute (Mondadori, 1989), Palma d’oro a Bordighera come miglior libro comico dell’anno.
Il Geniocidio è perpetrato quotidianamente, se con genio si intende quella parte divina, santa, protettrice o angelica che fa vedere cose che non si vedrebbero. Noi quotidianamente uccidiamo questa parte. È un geniocidio continuo. Il geniocidio non è così violento come il vero genocidio, ma è pur sempre violento perché spesso arriviamo al genocidio attraverso il geniocidio, perché con il genocidio togliamo a una persona, che potrebbe eliminare altri uomini, quel genio, quella forza, quell’angelo che gli dice cosa sta facendo, lasciandolo senza poetica. Abitualmente pensiamo al genio, come genio del lavoro, dell’arte, ma non pensiamo che esiste un genio del tutto. Poi c’è la genialità: la facoltà di inventare, ma è già una seconda zona di lavoro.
E il creame?
Il creame, non è la creatività che lascio alla moda, alla pubblicità, il creame è proprio quel lavoro di energia, di potenza, di fuoco, di urgenza, di voci che dicono: fai, inventa, scopri. L’estro è invece la scintilla, l’occasione. L’estro è lo sfregare due pietre. In mezzo c’è tutta la perdita di tempo assoluto e devastante in rivoli tra l’ironia, la satira, la paura, il solletico, l’ovvio, che non permetteranno mai che il geniocidio si fermi.
Genocidio-geniocidio, su molti siti web il suo spettacolo al Festival della Mente era citato come “No al genocidio”, non ha mai avuto paura di essere frainteso?
Ho una paura rovinosa; come sarà per il mio prossimo libro dal titolo “L’amorte” e tutti i giornali scriveranno “La morte”. È però un rischio che non smetto di prendermi. Il geniocidio mi serve anche per dire questo.
Affabulatore, giocoliere delle parole,nei suoi monologhi c’è un attento uso delle parole, che a volte inventa come nel caso di geniocidio. Quale parola secondo lei descrive meglio questo periodo?
Io ho dei grossi dubbi che questo sia un periodo storico, questo è un momento… la parola …non vorrei dire la fantasia, che è superata dalla realtà, non voglio dire disperazione, ecco, posso dire disparazione, le cose più disparate.
Nel libro Bastasse Grondare si è cimentato con le arti figurative, che rapporto esiste tra le parole e la grafica di Bergonzoni?
In quel momento con la casa editrice Scheiwiller fu un tentativo - che rifarò tenendo distinte l’arte dalla letteratura - fu l’idea di uno storyboard, di un lungo inciso. Il collegamento tra parole e grafica esiste, è il bisogno di non fermarsi al segno, il bisogno di sentire la chiamata che il segno fa della lettera. Mentre faccio il tratto di un viso, quel tratto va a chiedermi immediatamente: “Perché non usi la parola insieme a quel tratto?”. Io sono tutto collegato, non c’è niente che possa essere scollegato, infatti mentre guardo, muovo una gamba, il cuore batte, i capelli continuano il loro iter. Noi dividiamo tutto, prima fai arte, poi fai il poeta, poi fai l’attore, ma è tutto collegato, è contemporaneo, è tutto la stessa cosa.
Calligrafia: la creatività nella scrittura
intervista di Luca Barcellona
In cosa consiste il mestiere del calligrafo?
La mia visione di questo mestiere è quella di un artigiano che mette la sua conoscenza della “bella scrittura” al servizio del testo. A seconda di quanto ampio è questo background, un calligrafo può scrivere dei semplici inviti, diplomi, onorificenze, fino ai manoscritti veri e propri; si può applicare la calligrafia alla grafica con la creazione di loghi, lettering e caratteri tipografici, o fare della scrittura il mezzo espressivo per la produzione artistica. È un mestiere apparentemente desueto, ma che invece fa parte del linguaggio visivo a tutti gli effetti, specialmente se applicato alle nuove tecnologie.
Luca Barcellona, formatosi come grafico e writer, insegna calligrafia all'Associazione Calligrafica Italiana. I suoi studi nel lettering spaziano dalla tipografia alla stampa con caratteri mobili, dalla calligrafia classica a quella espressiva e sperimentale, fino alle performance su grandi pareti. Le lettere sono la componente principale delle sue creazioni, dove convivono la manualità di un'arte antica come la scrittura e i linguaggi e gli strumenti dell'era digitale. Tiene workshop e conferenze in tutto il mondo; molti marchi hanno richiesto i suoi lettering e i suoi lavori sono stati esposti in varie gallerie e musei di numerose città, tra cui Zurigo, Milano, Melbourne, Sidney, L’Aia, Praga., 2012).
Come si diventa calligrafi?
Credo sia necessario amare le lettere, ed essere curiosi, avere voglia di imparare più tecniche e stili possibili, dato che per ogni tipo di messaggio esiste una forma di lettere adatte ad esprimerla. La calligrafia è tradizione, storia, disciplina ed allenamento ed inventiva, non si può prescindere da questi elementi per potersi definire “calligrafi”.
La calligrafia è una forma d’arte?
Ricordo che sono sempre stato attratto dalla firma dei pittori nei quadri. Pian piano ha preso forma in me il desiderio che quella firma potesse in qualche modo diventare “IL” quadro. Sicuramente l’aspetto umano di ogni calligrafo è evidente nelle lettere che scrive, anche se parliamo di scritture di 1200 anni fa. Ognuno mette il proprio tocco, anche su modelli identici di alfabeti si possono distinguere le peculiarità di chi scrive, ed è questo il bello, quando la scrittura diventa espressione di se, fino a liberarsi dal significato e a prendere forme completamente astratte. Grandi calligrafi come Brody Neuenschwander e Thomas Ingmire hanno dimostrato come la scrittura possa essere l’elemento principale di una forma di pittura basata sulle lettere viste come immagine, e non come un messaggio da poter leggere. Per questo mi piace dire che la leggibilità è nostra nemica!
Calligrafi vs writer, sono due diversi approcci culturali?
Sono due mondi completamente diversi, eppure accomunati dalla passione per le lettere e per la scrittura. Il writing è stato il mio primo approccio, quello più istintivo e fuori dalle regole. Regole che invece sono state basilari quando ho deciso di prendere la calligrafia seriamente. Il mio obbiettivo di questi ultimi dieci anni è stato quello di far incontrare e dialogare questi due mondi, anche se forse si guardano reciprocamente in maniera ancora un po’ superficiale, credo che qualche piccolo passo sia stato fatto in proposito.
Quali sono gli strumenti del suo lavoro?
Nulla di troppo ricercato o costoso, a volte basta un semplice pennino e del buono inchiostro. Ci vuole lo strumento giusto per ogni scopo, ad esempio uso parecchio il pennello cinese con inchiostro sumi, meglio se po’ rovinato dall’usura, o i pennelli a punta piatta perchè permettono forme incredibilmente morbide e variabili attraverso la torsione delle setole in movimento. Ci sono strumenti costruiti artigianalmente, come tiralinee e colapen (penne artigianali fatte con l’alluminio delle lattine) che danno risultati eccezionali, l’importante è saperli controllare. La casualità di una lettera inaspettata, dove l’inchiostro schizzando sulla carta l’ha resa unica, dev’essere il risultato di un esercizio costante e continuo.