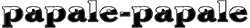Cinema
Uno sguardo retrospettivo
Rashomon
La fede nell’uomo, l'unica verità possibile
di Emanuela Sabbatini
La verità è conoscibile? E se sì, è comunicabile? Due domande, queste, sulle quali ci siamo interrogati sin dal primo appuntamento della Popcrime di quest’anno. Giunti al terzo incontro, quello conclusivo, andiamo a scoperchiare l’otre che Eolo aveva regalato ad Ulisse, e con “Rashomon” non raggiungiamo un porto sicuro ma ci perdiamo nuovamente nell’oceano dell’interrogazione filosofica.


La vicenda narrata dal capolavoro di Kurosawa è di fatto semplice. Un viandante, un monaco e un taglialegna si raccolgono alle porte della città di Kyoto, sotto la rovina di Rashomon, per ripararsi dalla pioggia battente. Qui inizia un terribile racconto. Il film si svolge attraverso la pratica fiabistica dello storytelling. Un samurai viene trovato morto in una foresta. Le versioni relative all’omicidio del guerriero sono quattro e sono tutte discordanti. Il bandito Tajomaru, accusato dell’omicidio, dichiara alla polizia di essere stato lui. Dopo aver stuprato la moglie del samurai, infatti, era stato sollecitato dalla donna, a battersi con il marito per salvarle l’onore. Da questa lotta il bandito ne sarebbe uscito vincitore, condannando alla morte il guerriero. Al contrario, la donna sostiene che, dopo lo stupro, leggendo negli occhi del marito tutto il disprezzo e la freddezza che provava ormai per lei, lo avrebbe incitato ad ucciderla, senza successo. Stremata dal dolore e svilita sarebbe poi carambolata sul corpo del marito ed accidentalmente lo avrebbe pugnalato col coltello che gli porgeva per giustiziarla. Lo spirito del samurai, interpellato da una medium, invece, dichiara di aver scelto il suicidio pur di sfuggire al dolore provato. L’ultima versione è poi quella del narratore, il taglialegna che racconta di essere testimone oculare dell’accaduto. Tajomaru infatuato dalla donna, le avrebbe chiesto di scappare con lui. Lei lo avrebbe incitato a battersi con il marito per amore suo. Il samurai però si sarebbe rifiutato di battersi per una sgualdrina. Colpita da tanta cattiveria e disonore, la donna avrebbe poi architettato un piano per indurli a battersi non in maniera leale e nel frattempo si sarebbe data alla fuga.
Ad eccezione dell’ultima versione, le altre tre concordano nell’aderire ad una caratteristica comune. Chi racconta è chi si dichiara colpevole del delitto. È un tratto di stranezza questo: quante volte in un film abbiamo assistito ad una lotta per accaparrarsi la colpa di un reato? I personaggi qui non sono legati da un rapporto di affetto tale che incolparsi del crimine possa essere letto come un atto d’amore in favore dell’altro. L’assunzione di colpa ha qui un sapore molto particolare. A ben vedere, nessun omicidio è veramente voluto. Vale a dire: Tajomaru uccide perché spinto dalla donna, quest’ultima accoltella il marito per errore, e il samurai si uccide ma per colpa del dolore provocato dall’accaduto.


La responsabilità dell’atto viene cioè gradualmente spostata verso l’altro. Ed allora quel “Non capisco il perché” che pronuncia il taglialegna e che apre il film è davvero la ricerca di quel senso che manca
E manca non solo perché non si intende il reale svolgimento dei fatti, e quindi vi è la negazione del valore epistemico della verità, ma anche perché a mancare è quell’umanità, quella fede nell’uomo che l’altro personaggio della storia, il monaco, ricerca. L’accaduto è davvero terribile “perché uccide la fiducia negli uomini”, dirà il monaco buddista. E la uccide non solo in quanto menzogna ma anche in quanto finta assunzione di colpa.
La fede, la pulsione verso l’Assoluto, colei che ha “la risposta per tutte le cose”, davanti al fatto non può nulla, perché l’uomo è un mistero per l’uomo stesso. Il punto è dunque doppio.
Per un verso la verità non è conoscibile perché l’uomo è miserevole, “è debole, e per questo deve mentire”. La menzogna è qui la soluzione alla miseria umana, alla sua pochezza di fronte all’Assoluto.
“Ma tu credi negli uomini onesti? Ognuno pensa di esserlo ma non lo è” dice il viandante ed aggiunge “ci ricordiamo solo di quello che ci fa comodo e siamo pronti a credere anche al falso quando ci fa comodo”. Questa falsità attribuibile alla debolezza è connaturata all’uomo, addirittura pare sopravviverle, tanto che persino le parole del morto vengono tacciate di menzogna.
Dall’altra parte però è la parola a rendere la verità impronunciabile. Durante l’interrogatorio della polizia, il prete infatti dice “Tajomaru aveva descritto una donna che non sembrava lei”.
Il bandito descrive l’accaduto e nel farlo sceglie dei termini che delineano il profilo della donna violata. L’immagine che ne traiamo è quella di una donna scaltra, maligna, calcolatrice, capace di usare la bellezza e le lacrime a proprio vantaggio. Quella che si trova davanti il monaco è invece una figura femminile disperata e affranta, delicata, debole. La parola è sempre quindi strumento di menzogna. Essa veicola una dichiarazione falsa oppure risponde ad un criterio percettivo personale che, nella soggettività alla quale obbedisce (da qui l'effetto rashomon), diventa falsa per qualcun altro.
È probabile cioè che Tajomaru abbia avuto quella percezione della donna, che di fatto l’abbia interpretata, vissuta, come scaltra e malvagia, e che quindi le parole siano vere nell’obbedire a quella percezione. Eppure quella definizione può essere falsa per la percezione di qualcun altro.


Ed allora la questione si apre ad altre innumerevoli problematiche: quello che percepisco è quello che è? Se non lo è, quello che racconto è suscettibile dei criteri di verità e falsità?
La verità risulterebbe quindi naturalmente irrisolta. Eppure tutti, in un breve momento, pare la stiano contemplando. Vi sono occasioni in cui tutti i personaggi guardano al cielo nei frangenti più disparati. Tajomaru guarda il cielo quando è legato come una bestia al comando di polizia; il taglialegna, il viandante e il monaco rivolgono lo sguardo al cielo quando indugiano raccontando l’accaduto e un fulmine pare fare da contrappunto all’efferatezza del narrato; la donna si arrende al bandito durante lo stupro e guarda il cielo. Quel senso mistico che il film asseconda, enfatizza la connessione tra alto/cielo e Assoluto/Vero e numerose altre simbologie. Ma non si tratta di un misticismo vero e proprio. Nulla che abbia a che fare con un discorso di fede religiosa. La fede qui è nell’uomo, quella che alla fine Kurosawa salva con l’atto di adozione del bimbo abbandonato dietro la porta di Rashomon, da parte del taglialegna. È questo gesto a risolvere ogni atto malvagio e cinico consentendo all’umanità di compiere quel ciclo rinnovatore del Samsara buddista: dalla morte con cui si apre il film, alla vita nuova di un vagito di bimbo.