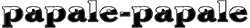Cultura e societÀ
Come fiori di ciliegio
Oriente tra filosofia e religione
di Luigi Capano

I ciliegi romani di via Panama che fremono alle timide correnti d’aprile, lasciando sull’asfalto un candido strame di luna, possiedono l’incanto sottile delle cose belle che muoiono senza rammarico; e rilucono, in virtù di una lontana origine, del mirabile dono proustiano della reviviscenza.
Nel 1942, assieme agli altri, che ombreggiano il laghetto dell’Eur, l’imperatore Hirohito li offrì all’Italia alleata in segno d’amicizia.
Il sakura, il ciliegio in fiore, è uno dei simboli più pregnanti della tradizione giapponese.
Fra i fiori il ciliegio, fra gli uomini il guerriero, recita un antico proverbio.
Superati i crudeli rigori invernali, i ciliegi salutano la primavera con una meravigliosa esplosione di fiori. È una festa breve ma intensa che termina con i primi venti d’aprile.
Così il guerriero, il samurai, nel fiore degli anni, nel pieno del proprio vigore fisico, muore sul campo di battaglia distaccandosi, silenzioso e imperturbabile, dal sakura dell’esistenza.
Immagini inattuali queste, immagini che sembrano lontanissime dalle nostre vite, e che il fiore di ciliegio, proustianamente, può evocare.
Nel cielo di Okinawa - verso la fine del 1944 – molti giovani piloti caddero come fiori di ciliegio. Erano gli uomini che avevano risposto all’appello dell’ammiraglio Onishi, comandante delle forze aeree della marina imperiale che, in un disperato tentativo di salvare il Giappone dall’invasione americana, aveva disposto la formazione immediata delle Forze speciali d’attacco Vento Divino, per sferrare un’ultima offensiva contro le portaerei nemiche.
Nel corso della sua storia, l’arcipelago nipponico non era mai stato invaso né occupato; né l’esercito imperiale era mai stato sconfitto.
Soltanto Kublai Khan, l’imperatore mongolo della Cina, di cui Marco Polo scrisse nel suo celebre memoriale, nel 1274 fu a un passo dal successo: ma allora si scatenò un vento miracoloso che respinse gli invasori.
E, in quella occasione, si parlò, per la prima volta, di un kamikaze, di un vento degli dei che avrebbe protetto la terra dei padri dall’onta dell’invasione.
I kamikaze dell’ammiraglio Onishi morirono a migliaia: tutti giovani tra i venti e i venticinque anni. L’azione – scrive Yukio Mishima, moderna incarnazione dello spirito guerriero - ha il misterioso potere di compendiare una vita nell’esplosione di un fuoco d’artificio.
Di passata giova puntualizzare che nulla hanno a che fare questi olocausti di guerra con quei balordi di altre latitudini e dai cervelli contratti da astruse ideologie religiose, cui viene oggi impropriamente rivolto l’antico epiteto.
Dopo l’ultimo disperato tentativo dei kamikaze, prima dell’invasione degli americani, i giapponesi trassero dai templi i grandi tamburi rituali, li portarono sulle spiagge e li suonarono per un’intera notte - raccontava Placido Procesi, maestro di tiro con l’arco (kyudo) e profondo conoscitore della tradizione nipponica, con cui ho avuto indimenticabili colloqui nella sua bella casa a due passi dalle mura leonine - Cercavano, con uno strumento magico, di risvegliare gli dei per l’ultima, estrema protezione. E tutto il Giappone risuonò del palpito di quei tamburi. È un ricordo che mi ha sempre commosso.
Placido Procesi è stato un pioniere degli studi yamatologici in Italia e il suo nome merita di figurare accanto a quelli di Pietro Silvio Rivetta, di Salvatore Mergè, di Fosco Maraini.
Da quando gli insegnamenti del Buddha hanno raggiunto la terra di Yamato. sul finire del IV sec. d.C., l’ombra dell’impermanenza si è allungata a coprire ovunque la scena della vita nipponica tradizionale, quel mondo dei fiori e dei salici, delle cose transeunti che durano il tempo di un respiro.
È l’universo iridescente delle cose belle che svaniscono, che i giapponesi vedevano materializzarsi soprattutto nel giro effimero degli attori, dei teatri, delle geisha, delle mantenute, dei piaceri di un momento.
La vita terrena è Ukyo-e, il mondo che galleggia, sottoposto a quell’immutabile legge del mutamento che si disvela alla mente immacolata - non maculata - nei riti della semplice esistenza quotidiana degli uomini e della natura, nel silenzio contemplativo del claustro, nella scarna essenzialità di un haiku, il poemetto di tre versi che compendia un’esperienza dell’anima.
È, questo, il clima metafisico e insieme antimetafisico dello Zen, per cui qualunque cosa può diventare un torii: un passaggio, una porta attraverso cui l’uomo si purifica, per accorgersi alla fine che Il grande sentiero non ha porte, Migliaia di strade vi sboccano. Quando si attraversa la porta senza porta, Si canmmina liberamente tra cielo e terra (Mumon 1183 – 1260).
Si può cogliere, da questi brevi cenni, quell’aspetto eversivo e antinomico dello Zen che è stato prudentemente ignorato nella versione addomesticata della dottrina diffusa in occidente.
Dal buddhismo zen, definito la religione dei samurai (Kaiten Nukariya), è nato, all’inizio dell’epoca feudale (XII sec.) l’ideale cavalleresco e guerriero giapponese che molto più tardi (verso la fine del XIX sec.) fu chiamata Bushido, la via del bushi, del soldato il cui unico possesso è la spada.
L’orientalista Wilhelm Gundert in una conferenza tenuta il 4 aprile del 1941 all’IsMEO – il prestigioso 'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente fondato nel 1933 da Giovanni Gentile e Giuseppe Tucci - ricordava che il bushido è vivo tuttora nell’esercito giapponese e in altri ambienti. Oggi ancora si possono incontrare molti ufficiali giapponesi che studiano a fondo gli scritti d egli antichi maestri dello Zen e prendono talvolta parte a meditazioni nei monasteri.
Non molto tempo fa – era un afoso sabato di giugno - sono andato a far visita al professor Filippani Ronconi, vecchio combattente di mille battaglie durante l’ultima guerra. L’ho trovato stanco e malato, e a stento abbiamo potuto scambiare qualche parola. È grave – mi ha detto - ma non me ne importa un fico secco. Vado incontro alla mia morte. Di cosa dovrei aver paura?
Oltre al Butsu-do, la via del Buddha, altre due grandi forze spirituali hanno contessuto la civiltà tradizionale giapponese: l’austera etica di Confucio con i suoi precetti di ordine, dovere, lealtà, fedeltà, rispetto, benevolenza, miranti ad armonizzare l’agire umano con le leggi cosmiche del Cielo e della Terra; e lo Shinto, l’antica via degli Dei (Kami) che vede l’uomo, perfettamente a proprio agio nell’elemento naturale, condurre la propria vita prestando orecchio alla voce sollecita degli dei.
Un inno luturgico scintoista canta: La terra è la madre da cui tutte le creature hanno ricevuto l’essere e la vita. Tutte uniscono la loro voce all’inno universale. Grandi alberi e piccole erbe, pietre, sabbia, il suolo che calpestiamo, i venti, le onde hanno un’anima divina. Il mormorio delle brezze nei boschi a primavera, il ronzio del’insetto nelle erbe umide dell’autunno sono altrettante strofe del canto della terra. Sospiri della brezza, strepito del torrente: inni di vita di cui tutti debbono rallegrarsi.. Proprio in virtù di tale sensibilità il samurai può sentirsi vicino ad un effimero fiore di ciliegio.
Risale ai primi anni sessanta la nascita dell’Ankoku Buto – la danza delle tenebre – ideato da Tatsumi Hijikata e da Katsuo Ono, una forma di espressione corporea che, facendo propria l’esperienza delle grandi avanguardie artistiche europee, tenta di ristabilire, nel Giappone moderno, un rapporto più autentico con la natura e con la morte. Il danzatore, il corpo dipinto di bianco, muovendosi in uno spazio di tenebra subisce metamorfosi grottesche sperimentando in tal modo altre forme di esistenza.
In realtà, nella visione tradizionale non esiste separazione alcuna tra i vivi e i morti.
La morte è soltanto un morbido velo tra noi e i nostri cari che sono entrati a far parte della folta schiera dei kami. Accanto all’anima dei vivi c’è quella dei morti, esercito invisibile che domina il mondo e governa la storia. In realtà i morti non dormono al cimitero: continuano a vivere in noi e sono così i veri padroni delle nostre azioni” (conferenza dell’Ambasciatore Yotaro Sugimura, IsMEO, 30 marzo 1936).
Dopo questa lunga digressione proustiana, ci accomiatiamo dal Giappone per rientrare nel limite consueto della nostra quotidianità.
Le antiche storie così magicamente evocate cedono alla vivida concretezza del crepuscolo romano, che raccoglie uomini e cose in un velo ambrato di malinconica quiete. Anche in città la sera sa essere custode del silenzio.
Le immagini dileguano, i pensieri si ritraggono nell’imo più segreto.
Cadono le parole come fiori di ciliegio.