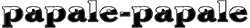Racconto d'altri tempi
La felicità di Celestinu
Storie dell’altroieri
di Agnolo Camerte
Celestinu aveva una casetta ai margini del paese. Era solo, non aveva nessuno.
Viveva di stenti, tirava a campare, si arrangiava.
A guardarlo, sembrava uscito da un quadro di Van Gogh, se non fosse stato per un sorriso perenne che gli illuminava gli occhi e che lo faceva sembrare felice e contento.
Si vedeva camminare accanto alla sua somara Garbatina, vecchia e spelacchiata come lui. Garbatina trainava un carrettino con il quale Celestinu faceva piccoli trasporti.
Una volta caricava una bombola di gas, da recapitare ai casolari della campagna circostante, un pacco, una sacco di grano, di farina ecc.
Poche cose e non tanto pesanti per non affaticare troppo la somara sulle salite.
Celestinu ci parlava con la sua Garbatina che sembrava lo capisse, poiché ogni tanto gli rispondeva con sonori ragli che si sentivano da lontano.
Chissà, forse voleva riposare un po’ e addentare qualche ciuffo d’erba che gli appariva appetitoso.
Celestinu la lasciava fare , soprattutto se capiva , ad esempio, che alla casa colonica, sarebbero così arrivati verso l’ora di pranzo... Sapevano tutti e due bene quanto fossero generosi certi contadini. E che vino avevano! A Celestinu piaceva tantissimo. Ne divideva un po’ solo con la sua amata somara. Che lo reclamava, quando ce n’era, con certe ragliate ritmiche che Celestinu capiva al volo, se non era già ubriaco o addormentato sul carretto . Beveva più vino lui che una macchina da corsa.
Garbatina era una somara giudiziosa. Quando, al ritorno, sentiva che il padrone si era addormentato, pensava lei a portarlo a casa. Percorreva a memoria la strada del ritorno , fermandosi immancabilmente davanti alle sette osterie della cittadina. Le faceva tutte, non ne saltava una!
Una bella ragliata per svegliare il padrone, che scendeva, si andava a fare la sua bevutina (la foglietta) di vino , e ne divideva sempre un po’ con lei.
Poi, ripartivano per le prossime osterie davanti alle quali Garbatina si fermava senza esitazione.
Arrivati a casa, Garbatina si riposava in una ampia stalla che era tutta per se. Una reggia! Greppia piena, paglia pulita erano per Lei segno tangibile dell’affetto del suo padrone.
Lui dormiva sopra la stalla, in un pagliericcio di foglie di granturco, buttato la come un sacco.
Aveva una casa poverissima Celestinu, eppure sembrava molto felice, contento della sua vita con la sua somara. Appariva sempre allegro e soddisfatto.


Ma un giorno lo incontrarono mogio mogio, solo, senza il suo solito sorriso in faccia, addirittura sobrio e gli chiesero come và? E la somara?
Rispose tristissimo: “ eh... è morta! Sta stupida! ...mò che aveva mparato a magnà solo la paja!...”
Da allora non lo si vide più con il solito sorriso e la... solita sbornia... Quasi fosse in lutto.
Tuttavia portò la sua povertà dignitosamente, sino alla fine, arrivata non molto dopo quella della sua somara.