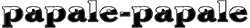Racconto
Memorie e Rovine
di Ruggero Scarponi
- Eh si! Amico mio – disse il professore mentre avanzava cauto, cercando di scansare pezzi di calcinacci e vecchi mattoni che ingombravano il sentiero sotto l’arco turrito che fungeva da porta del paese – si sa, chi viene qua da noi, nel Lazio, vuole andare subito a vedere Roma. E dagli torto! Roma “richiama”, si capisce!
- Naturale – assentii.
- Mio gentile amico – continuò il professore che si era fermato per fare una sosta, appoggiato con una mano al muro polveroso di una rovina – ascolti bene – disse ansante cercando di prendere fiato poiché il cammino in salita si era impennato e stava diventando faticoso – lei per esempio aveva mai sentito parlare, prima d’oggi, di Santa Maria di Galeria? Qui a due passi da Roma con la piccola chiesetta in stile gotico? No? E dell’antica Galeria? Ah, bene, non ne sa nulla. Giusto, sarebbe parso strano il contrario. Non è niente di che mi creda. A Roma c’è ben altro. Ma lo sa qual è la differenza? Lo sa perché non mi stanco di venirci e soprattutto di portarci gente come lei? Glielo dico subito il motivo...
Qui il professore però si arrestò un momento, prese un bel respiro, chiuse gli occhi e continuò a voce bassa quasi sussurrando.
- Lo sente questo profumo?
Istintivamente chiusi gli occhi anch’io come aveva fatto il professore e poi dopo averci pensato un istante, tirando su con il naso, dissi titubante:
- C’è... odore di fichi.
- Già - rispose il professore aspirando avidamente l’intenso effluvio emanante dai frutti maturi.
- Guardi un po’ sopra di lei.
Alzai lo sguardo e proprio sopra la mia testa notai a meno di un metro il ramo grigio-chiaro di un albero di fico che fuoriusciva prepotente dal muro di una vecchia casa. D’intorno c’era un groviglio di arbusti e di cespugli dai verdi intensi, quelli degli allori e dei corbezzoli, delle ginestre, dei lecci e delle querce e dei giovani pini dai tronchi color marrone chiazzato con gli aghi puntuti e diritti come gli aculei di qualche pianta spinosa.
- Queste sono rovine, sa, che crede? – ridacchiò il Professore. – A Roma le rovine sono, come dire, istituzionali. Hanno perso del tutto il “mistero della caduta”. In esse, chi le visita oggi, non avverte più la tragica grandezza della “fine”. Il “respiro maestoso del tempo”…Sembrano nate così, per essere ammirate come sono ora. Vede caro amico che già in epoca romana i templi, le colonne, gli archi, tutto sembrava predisposto per recitare al momento opportuno la parte che i secoli assegnano alle cose dell’uomo. Non era vera decadenza quella. Era tutta finzione a bella posta. Trasformazione piuttosto. Insomma era tutto un gran palcoscenico. Poi sono venuti i registi, infatti. Quelli incaricati di creare la messinscena. E allora ecco venir giù i Piranesi i Corot, e poi Goethe, Byron, …e il fascino misterioso del passato, ecc…Tutto un gran teatro amico mio, glielo dico io. Le cose stanno pressappoco così, prima Roma si è fatta bella di marmi, fregi, statue e architetture e poi passati i secoli invece di buttare tutto all’aria è come se avesse detto: “fossi matta”, con tutto quello che m’è costato! E allora cari turisti di tutto il mondo al prezzo di un biglietto intero vi do qualche “mezza porzione” e vi faccio pagare per nuovo, un tempio scoperchiato, una colonna smozzicata, un vecchio mascherone di fontana e così via…tutta roba che fa sognare, si capisce!
Ma non mi fraintenda, che altrimenti non l’avrei condotta qui. Era solo per dire che le rovine servono, eccome! Ma solo se uno vuole sentire il respiro maestoso del tempo, per altre cose non servono a nulla se non per ammazzare la noia del turista che se ne va in giro per non sa starsene a casa ad annoiarsi. Ma a Roma caro amico se vuole subire questa particolare suggestione non vada a zonzo per rovine, no. Lì le emozioni le vendono un tanto al chilo. Vada invece per conventi. Se ne meraviglia? Allora faccia la prova. Per esempio si faccia una passeggiata tra il Colosseo e San Giovanni in Laterano e vada a far visita a quelle suorine di clausura ai Santi Quattro, sono agostiniane, mi pare, e si faccia aprire l’Oratorio di S. Silvestro. Bussi alla finestra con la ruota, quella dove un tempo venivano abbandonati i “trovatelli”. Le daranno la chiave per accedere all’oratorio che loro, le suore, sono in clausura e non possono uscire e lei deve fare tutto da solo. Prende la chiave, apre l’oratorio, ci sta dentro il tempo che le pare e poi da bravo, riporta la chiave alla madre guardiana e se è persona sensibile, le lascia anche un’offerta che tanto le suore non gliela chiederanno di certo. L’Oratorio, dicevo. Ma non per quanto riguarda il contesto storico-artistico, di quello, se non è addetto ai lavori non capirebbe nulla. Si metta piuttosto in silenzio nell’angolo opposto al finestrone da cui giunge la luce del giorno. Faccia silenzio per favore, come le ho detto e possibilmente ci vada da solo. Se veramente è capace di far silenzio dentro di sé, allora a poco a poco lo avvertirà anche di fuori. Le pitture romaniche alle pareti non stanno lì solo per farsi ammirare, questo, sono in pochi a poterlo fare con vera cognizione, piuttosto se ne lasci riempire gli occhi, senza nessuna presunzione, con autentico abbandono, davvero, le sarà più facile perdersi nei labirinti interiori, per gustare nell’aria rarefatta e sospesa, la pienezza della solitudine. Allora scoprirà con sorpresa che in pochi posti al mondo la luce del sole sembra giungere da tanto lontano quanto nell’Oratorio di San Silvestro al primo mattino. E questa è proprio una di quelle suggestioni che io chiamo il “respiro maestoso del tempo”. Ci vada. Ne uscirà cambiato. Oserei dire più buono. Perché lì, i prescelti, imparando a conoscere il segreto del tempo diventano saggi. E solo chi diventa saggio ha qualche probabilità di diventare anche buono. Ma se vuole altre prove allora vada a trovare i Canonici a San Pietro in Vincoli, oppure i Domenicani a Santa Sabina o le Suore del Sacro Costato a Santo Stefano Rotondo. Non si meravigli amico mio. I preti e le monache sono rimasti gli unici, o quasi, che hanno cara la custodia del tempo. Forse per naturale inclinazione. Sta di fatto che presso qualche convento ti può ancora capitare di scendere la scala dei secoli in perfetta letizia e al riparo dalle volgari esibizioni commerciali. Ma prego, mi segua, - mi disse interrompendo la riflessione - sto facendo un sacco di chiacchiere inutili, mentre invece, siamo qui per visitare l’antico abitato di Galeria. Una città morta, lo sa? Da quanto? Non è molto chiaro, in proposito mancano dati sicuri. Chi dice a causa dell’invasione dei francesi ai tempi di Napoleone e chi invece a causa della malaria. La zona fino ai primi anni del novecento era paludosa. Fossi e acquitrini ovunque, acque stagnanti e zanzare. Potrebbe essere che i contadini locali sfiniti dall’anofele abbiano deciso un giorno ai primi decenni dell’800 di abbandonare tutto per un posto più salubre. Personalmente propendo più per questa ipotesi che per quella dei francesi invasori.
Il Professore tacque a questo punto, respirò profondamente e riprese il cammino.
Lo seguii per un tortuoso sentiero nella foresta di lecci, rovere e pungitopo. La vegetazione si era infiltrata ovunque tra le povere case dell’antico borgo di Galeria. Della vecchia chiesa dai muri sfondati, dai quali emergeva qua e là, tra mattoni smozzicati e residui di calcina secca, chiazze di un antico intonaco azzurrino, restava il campanile semi-diroccato ma ancora svettante al disopra della selva e contro il cielo blu scintillante.
Percorremmo l’intero periplo dell’abitato seicentesco. Entrammo in case e casette dalle mura sconvolte, dai tetti scoperchiati e colonizzate da una vegetazione rigogliosa e trionfante. In terra, tra arbusti e radici, c’erano a pezzi, sparse per ogni dove, antiche tegole rossastre macchiate del nero della pioggia combinata con l’humus terrigno e persino brandelli di povere cornici di stucco, in disfacimento, grigio e polveroso, provenienti da qualche nicchia di santi presso la chiesa o dalla casa di un artigiano. Una vecchia mola in pietra, bianca e levigata, testimoniava della presenza nel villaggio di un molino per la spremitura delle olive o per la macina dei cereali. Passammo oltre avidi di curiosità in quel viluppo di piante e muraglie cadenti. A mala pena si poteva scorgere ancora il tracciato di qualche via ma tutto appariva incredibilmente confuso, affiorante da un passato, fitto di veli e nebbie, di vapori e perdute memorie, quelle dei contadini, degli artigiani e di qualche curato di villaggio. Gente semplice, incapace e forse disinteressata a lasciare o a segnare le tracce del proprio cammino. Ma dalle case diroccate o dalla foresta di lecci e querce mi sembrava di cogliere incredulo la loro voce. Come richiami sempre uguali composti dalle parole gridate delle necessità quotidiane. Non si scorgevano da nessuna parte iscrizioni e nemmeno lapidi o monumenti ma solo si udivano evocati da chissà quali magie, i sospiri dei morti dimenticati, lasciati come panni stesi a seccare nel vento. Il professore che intanto si era allontanato girovagando qua e là, discese da un cumulo di detriti di quella che un tempo, forse, poteva essere stata una rimessa per gli attrezzi della campagna, o il ricovero di un asino. Lo aiutai. Era un uomo anziano e appesantito, ma negli occhi conservava una luce viva e lo sguardo era acceso. Ne fui commosso. Continuammo il giro percorrendo il perimetro esterno dell’antico abitato di Galeria. Resistevano ancora tratti di mura in mattoni di tufo ricoperti da muschi e capilvenere e in lotta da secoli contro un’incessante rete di edere rampicanti. Raggiungemmo in breve la sommità dell’antico abitato. Un alto sperone roccioso che si protendeva sulla campagna. In basso i campi di grano biondeggiavano e si estendevano fino al limite di una valle punteggiata da una lunga teoria di alberi scuri. Dietro, nella calma immobile di un mattino d’estate, scorreva lento e melmoso il torrente Arrone.